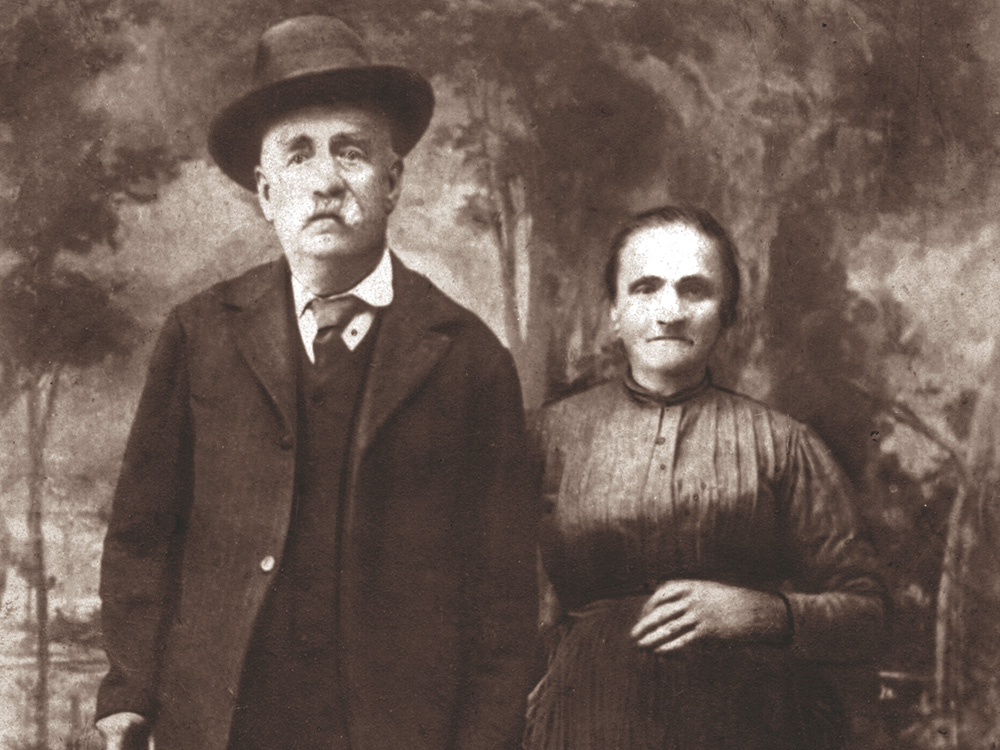
Nel medioevo, il termine “uomo d’arme” poteva indicare sia il soldato che il condottiero di alto rango, con il significato di “uomo dedito al mestiere delle armi”.
Il cognome Dell’Omodarme quindi significa “discendenti dell’uomo d’arme”. Non sappiamo chi fosse questo capostipite, ma con ogni probabilità si tratta di un cittadino pisano. La famiglia infatti risulta essere originaria di Pisa. Il gruppo più consistente viveva nella parrocchia di San Marco alle Cappelle, nei sobborghi della città, in località Portone.
Sul finire del Seicento, Matteo, Ranieri e Giuseppe dell’Homo d’Arme, inviarono una supplica − non sappiamo per quale ragione − al cardinale Francesco Maria de’ Medici, figlio del granduca Ferdinando II.
Nel Settecento sembra che almeno un ramo della famiglia avesse raggiunto una certa agiatezza.
Ad un ramo più popolano pare invece che appartenessero i Dell’Omodarme che, nella seconda metà del Settecento, cominciarono a frequentare Campiglia, mantenendo però con ogni probabilità la loro residenza a Pisa.
Si tratta di Giuseppe (1707ca.-1773), Ranieri (1742ca.-1766), un altro Ranieri (1753ca.-1791) e Orlando (1765ca.-1796).
Nel 1841 i Dell’Omodarme campigliesi vivevano in tre nuclei familiari distinti, anche se imparentati tra di loro.
Il primo ramo era quello di Raimondo (1790ca.-1857), figlio di Virgilio e Ginevra Di Prete, calzolaio sposato con Caterina Pulcinelli e padre di Teresa (1815) − futura moglie di Lorenzo Pacini − e di Felice (1816-1862). Raimondo era fratello di Giuditta (1788ca.-1858), che aveva sposato prima Fiorenzo Parrini e poi Francesco Bertelli.
Il secondo ramo era guidato da Domenico (1806-1862), figlio di Giovanni Battista e Verdiana Pacchiani e primo della famiglia Dell’Omodarme ad essere nato a Campiglia anziché a Pisa.
Il terzo ramo faceva capo a Santi (1799ca.), un quarantaduenne celibe che di mestiere faceva il carraio, insieme ai fratelli Ranieri (1804ca.) e Onorato (1806ca.) I tre, insieme a Lorenzo, altro loro fratello, erano figli di Angelo Dell’Omodarme, possidente pisano deceduto nel 1843.
Di quest’ultimo ramo facevano parte anche due popolari figure dell’Ottocento pisano, due noti e universalmente stimati esponenti repubblicani: i fratelli Attilio e Giuseppe Dell’Omodarme. Di “Beppe” − alla cui memoria a Pisa è intitolata una via − ci ha lasciato un bellissimo ritratto lo scrittore Renato Fucini (1843-1921), il quale ebbe modo di conoscerlo di persona.
Racconta il Fucini: «Rimasto solo a Pisa, mi ricordai che mio padre mi aveva dato una lettera di presentazione per Beppe Dell’Omodarme, il capopopolo di Pisa. I due giovani cospiratori s’erano incontrati e s’erano intesi a Campiglia Marittima dove mio padre risiedeva come medico della Commissione sanitaria, e dove Beppe capitava di quando in quando per sorvegliare una sua officina di carradore. Recatomi al Portone dove Beppe abitava, e non sapendo la sua casa, bastò che io rammentassi il suo nome perché alcuni popolani, guardandomi con simpatia, me la additassero e premurosi mi vi accompagnassero.
Beppe, come ebbi poi ad accorgermi, era il loro re, il loro imperatore, il loro Dio. Egli era un bell’uomo per l’alta e robusta persona, ma non bello di viso per causa del naso rincagnato come quello di Michelangiolo. Ma il lampeggiare dei suoi occhi e il vigore e la bontà dell’animo che scaturivano da quei lampi, lo facevano a prima vista simpatico e quasi bello. Parlava rozzo e a sbalzi, intercalando circa dieci bestemmie fra mezzo a cinque parole; e, parlando, lavorava di bracci e di mani con tanta energia che ne seppe qualche cosa il mio esile corpicciuolo quando fu investito dalle sue carezze.
“Pezzo di sbarazzino! Dio…! O che sei ‘l figliolo der mi’ Davide?! O quant’anni hai? Qua, Dio…, dammi un bel bacione collo schiocco e io te ne dò due: uno per te e uno per el tu’ babbo. Che sei venuto qui a studiare? O quando sei arrivato?… Hai bisogno di nulla? Vòi mangiare? Vòi bere? Giù, mettiti a sedere e ricordati. Madonna…, che qui sei come in casa tua!…” E mi strizzava e mi sballottava amorosamente con quelle sue mani pelose che erano grosse e calde come il suo cuore.
Ho detto che egli era il re, l’imperatore, il Dio dei popolani di Pisa. Era vero. Cedendo al fascino di quell’anima onesta e generosa se lo erano eletto spontaneamente per loro capo, e dipendevano così fiduciosamente da lui che una sua parola, un suo cenno, una sua bestemmia erano capaci di ridurli all’istante da tigri in conigli e viceversa. Ed ebbi occasione di vederlo più volte alla prova.
Una sera di carnevale, pochi giorni dopo la morte di Cavour (1861), si sparse per Pisa la voce che nel palazzo Scotto, sui Lungarni presso il ponte della Fortezza, l’aristocrazia nera della città doveva riunirsi per festeggiare con un ricevimento e con un ballo il triste avvenimento che aveva messo nel lutto tutta l’Italia. Non so se lo scopo della festa fosse veramente quello attribuitole; ma tutti prestarono fede a quella voce. La popolazione era in fermento; gli scolari non stavano alle mosse per mostrare il loro sdegno e per impedire agli sciagurati austriacanti la vergognosa e imprudente dimostrazione. Verso l’imbrunire incominciarono a formarsi dei capannelli dinanzi al caffè dell’Ussero, e in poco tempo tutta la scolaresca, meno gli ammalati, credo io, era lì radunata, con le mani sui bastoni e con gli occhi al triste covo reazionario. Fra le nove e le dieci incominciò il via vai delle carrozze sulla piazzetta che si slarga dinanzi a quel palazzo, e da molte delle sue finestre principiò a farsi viva la sfarzosa illuminazione dell’interno. Passarono alcuni quarti d’ora che alla impazienza di tanti giovani parvero secoli, e finalmente, avuto avviso da alcuno delle nostre scolte che il ballo era incominciato, tutti, in un folto gruppo, seguiti da un nuvolo di popolani, ci muovemmo a passo di carica per entrare in ballo anche noi. Da prima urli, fischi e imprecazioni, poi sassate ai vetri alti e bastonate a quelli del piano terreno; e, da ultimo, con un crescendo infernale, tonfi al portone e botte di bastoni, di mazze ferrate e di pali, fatti capitare nelle nostre mani non si sa da qual parte né da chi.

Il contagio della furia si allargava pericolosamente, i più tranquilli erano diventati i più furibondi, e l’affare minacciava di farsi molto grave. Nel palazzo doveva esservi lo spavento. L’illuminazione si spense a un tratto e si udirono grida e si videro ombre di persone fuggenti le quali, come fu risaputo dopo, scappavano terrorizzate attraverso ai giardini e si disperdevano per una porticina segreta in fondo al recinto. Intanto i colpi nel portone raddoppiavano nonostante che un delegato urlasse e si sbracciasse dall’alto d’una carrozza. Vennero guardie, vennero carabinieri e venne anche il Prefetto in persona; ma le minacce di quelli e gli argomenti di questo non valsero a nulla: il clamore e i tonfi intorno a quel povero portone crescevano col crescere della sua resistenza. Non so a chi venisse la buona ispirazione d’avvisare Beppe Dell’Omodarme, il quale, nel momento proprio urgente comparve, e lavorando di braccia come se nuotasse di spasseggio sulle nostre teste, venne a mettersi in mezzo al tumulto gridando: “Ragazzi, Dio….! o che stasera avete perso il giudizio peggio di quelli lassù che ballano?! Che noia vi danno? O che forse, Dio…, o che forse son venuti a ballare in casa vostra? Lasciateli sfogare la bile che hanno ne’ buzzacci verdi e finiamola! Finiamo le ragazzate; e voi, se volete bene al vostro Beppe, Dio…! tutti a casa, tutti a casa, Madonna…., e subito! Se no, sculaccioni a iosa e a letto senza cena!” Una formidabile risata accolse la ciceroniana allocuzione di Beppe, un lungo applauso soffocò la sua voce, e fu intorno a lui una ressa dei più vicini, che gli s’avventavano addosso per abbracciarlo. Una mezz’ora dopo la piazzetta era tornata deserta e tutto il rumore dell’avvenimento s’era allontanato silenziosamente verso le desolate regioni dell’oblio.
Giacchè mi è capitato di parlare di questa bella e generosa figura di popolano, non voglio lasciarla senza prima raccontare un altro fattarello che serve a illuminarne l’originalità.
Beppe Dell’Omodarme, trovandosi in ristrettezze economiche dopo aver dato quasi tutto il suo alla causa dell’indipendenza italiana, fu chiamato, per suggerimento di molti patriotti, da Vittorio Emanuele II a coprire un impiego sufficientemente lucroso nell’amministrazione delle caccie reali di San Rossore. Per quello che ne aveva sentito dire e piacendogli a prima vista la maschia figura di Beppe, il Re volle averlo spesso accanto, nelle cacciate. Ma, conversando poi coi suoi intimi, si mostrò un po’ deluso, dopo quello che dal fiero popolano si aspettava, perchè lo aveva trovato troppo taciturno. Ed era vero. Non essendo libero di bestemmiare a suo piacere, Beppe non sapeva aprir bocca dinanzi al Re, o, se l’apriva, non erano che poche parole e molte reticenze accompagnate da forti stringimenti di pugni e stralunamenti d’occhi e rabbiose grattature di capo.
Vittorio Emanuele che nel suo animo di soldato e di cacciatore aveva un largo fondo di buontempone, fece sapere a Beppe che anche dinanzi a lui avrebbe potuto parlare liberamente, secondo la sua usanza. Beppe non se lo fece dire due volte. Qualche sacrifizio e qualche soppressione avrà dovuto imporre al suo linguaggio abituale; ma diventò immediatamente il Beppe di prima anche dinanzi al Re che spesso si compiaceva di stuzzicare la sua facondia, invitandolo a parlare di politica e di caccia. Questo io seppi da una persona del seguito reale con la quale ebbi intimità molti anni dopo.
Pare che a quei tempi il nome di Giuseppe fosse apportatore di buone promesse e di buona fortuna: Beppe Mazzini, Beppe Garibaldi, Beppe Giusti, Beppe Dolfi capopopolo adorato dei fiorentini, Beppe Dell’Omodarme e chi sa quanti altri Beppi celebrati dalle popolazioni e non conosciuti dalla storia, nelle piccole città, dai larici di Susa ai fichi d’India di Trapani. Ora i capipopolo non usano più. Con una spudorata finzione d’altruismo, oggi, ogni ventre pensa per sè, e, abolito Cristo, altro non adora che l’osteria per fabbricare dello sterco evoluto e cosciente».
Riassumiamo di seguito le principali notizie genealogiche della famiglia Dell’Omodarme a Campiglia, dalle origini fino a oggi.
figli di Giovanni Battista di Domenico: 1) DOMENICO, n. 1806, sp. 1824 con Maria Annunziata Ciacchini (1805-1856), m. 1862.
figli di Domenico e Maria Annunziata Ciacchini (sp. …): 1) Giovanni Battista, n. 1825, m. 1826. 2) Rosa, n. 1828, sp. 1848 con Rocco Guidi (1823-1889), m. 1883. 3) Maddalena, n. 1831, m. 1832. 4) Elisabetta, n. 1833, sp. 1856 con Giuseppe Nannicini, m. 1871. 5) PIETRO, n. 1837, sp. 1857 con Eufemia Pugli (1838-1906), m. 1900. 6) ANTONIO, n. 1840, con Giuseppa Finucci (1848-…), m. 1923. 7) GIOVANNI BATTISTA, n. 1843, sp. 1871 con Maria Pellegrina Castelli (1843-1916), m. 1905. 8) Antonia, n. 1846, sp. con Marco Cecchini (1842-1899), m. 1911. 9) Oliva, n. 1849, sp. … con Giacomo Mori, m. …

figli di Pietro e Eufemia Pugli (sp. 1857): 1) Maria Antonia Annunziata, n. 1860, m. 1861 2) Cammillo, n. 1861, m. 1862. 3) Domenico Giovanni, n. 1863, m. 1865. 4) Fortunato, n. 1865, m. 1865. 5) ANGIOLO, n. 1865, sp. 1892 con Albina Biagi (1874-1945), m. 1941. 6) Annunziata, n. 1867, m. 1869. 7) Cammillo Alceste, n. 1869, m. 1869. 8) Emilia, n. 1870, m. 1873. 9) Ester, n. 1872, sp. 1892 con Francesco Federighi (1867-…), m. 1907. 10) Annunziata, n. 1875, sp. 1893 con Pietro Fantozzi (1872-…), m. 1953. 11) Emilio, n. 1880, m. …
figli di Giovanni Battista e Maria Pellegrina Castelli (sp. 1871): 1) Elisabetta, n. 1872, sp. … con Pietro Lazzeretti, m. … 2) Maria Anna “Orsola”, n. 1874, m. … 3) Stella, n. 1876, sp. 1901 con Adriano Pecchia (1878-…), m. 1952. 4) Fiorenzo Pasquale Luigi, n. 1879, m. 1884. 5) Margherita, n. 1882, m. 1883.
figli di Antonio e Giuseppa Finucci (sp. …): 1) Giovanni, n. 1872, m. 1875 2) Anna, n. 1873, sp. 1902 con Sperandio Baldassarri (1882-1917), m. 1939. 3) Assunta, n. 1875, m. 1876. 4) ALBERTO, n. 1877, sp. 1901 con Maria Peccianti (1879-1964), m. 1953. 5) DOMENICO, n. 1879, sp. 1902 con Elisa Parlanti (1880-…), emigr. 1912 a Gavorrano. 6) Rosa, n. 1881, m. … 7) DANTE, n. 1882, sp. 1907 con Eugenia Guzzarri (1889-…), m. 1958. 8) Maria Teresa Assunta, n. 1884, m. 1884. 9) Fanny, n. 1885, sp. 1907 con Antonio Guarnieri (1883-…), m. 1950. 10) Celestino Alfredo Marino, n. 1887, m. … 11) Assunta, n. 1889, m. 1889.
figli di Alberto e Maria Peccianti (sp. 1901): 1) Giovanni, n. 1902, m. 1902. 2) SIRIO, n. 1904, sp. … con Evelina Cristiani, m. 1977 3) Francesca, n. 1906, m. 1914. 4) Giuseppina, n. …, sp. Gallipole Cristiani, m. …
figli di Domenico e Elisa Parlanti (sp. 1902): 1) Antonio, n. 1903, m. … 2) Dino, n. 1905, m. … 3) Dina, n. 1908, m. … 4) Annita, n. 1912, m. …
figli di Dante e Eugenia Guzzarri (sp. 1907): 1) Aladina, n. 1908, m. 1913. 2) GIOVANNI, n. 1910, sp. 1933 con Olga Casagrande (…-…), m. … 3) FIORENZO, n. 1912, sp. 1937 con Alba Paini (…-…), m. … 4) Aladina, n. 1914, sp. 1935 con Fabio Giannini (…-…), m. … 5) Marino, n. 1920, sp. 1944 con Gina Bianchi (…-…), m. 1972. 6) GIULIO, n. 1922, sp. 1947 con Ilia Giorgerini (…-…), m. 2010. 7) Emma, n. 1924, sp. 1944 con Eto Rombai (…-…), m. 2014. 8) Romano, n. 1934, sp. … 9) Benito, n. 1934, sp. …, m. 2014.
figli di Sirio e Evelina Cristiani (sp. …): 1) Mila, n. 1931, sp. 1949 con Fulvio Forenzani (1924-1984), m. 2006. 2) LIDO, n. 1938, sp. 1975 con Concetta Gaudio (1947-2016) 3) Nada, n. 1929, sp. 1967 con Pietro Calzolari (1935).
figli di Giovanni e Olga Casagrande (sp. 1933): 1) Iliana, n. 1934. 2) Ilvano, n. 1940.
figli di Fiorenzo e Alba Paini (sp. 1937): 1) Maria Angiola, n. 1939.
figli di Giulio e Ilia Giorgerini (sp. 1947): 1) Paolo, n. 1948. 2) Sergio, n. 1954.
figli di Lido e Concetta Gaudio (sp. 1975): 1) Adriana, n. 1976. 2) Fabrizio, n. 1981
© 2018 – 2022, Valdicorniacult.it – Riproduzione riservata.






